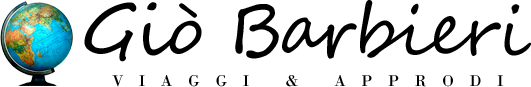In Somalia da Gibuti via terra
Entrati in Somalia da Gibuti via terra, con passaggio su un camion Aldo ed io attraversiamo la parte settentrionale del Paese, ovvero la regione del Somaliland che aspira a diventare uno Stato indipendente. Nel 1884 l’impero britannico fondò la Somalia Britannica su quel territorio oggi noto come Somaliland. Il 26 giugno 1960 ha ottenuto l’indipendenza dal Regno Unito e pochi giorni dopo si è unita all’ex Somalia Italiana per formare la Repubblica di Somalia. Unione mal riuscita che sfocerà in una feroce guerra civile e porterà il Somaliland a dichiarare la propria indipendenza non ancora ufficialmente riconosciuta.
Lungo il percorso incontriamo sacche di miseria e denutrizione che lasceranno tracce indelebili nella nostra memoria, frutto di clan tribali ancora padroni e di una instabilità politica che sembra non trovare soluzione. Ospiti per un paio di giorni dei ragazzi della ditta italiana Pessina, riprendiamo il viaggio verso Mogadiscio. Maurizio di Modena, con un mezzo della stessa ditta, alle 6,30 ci accompagna al bus che fa servizio da Hargheisa a Mogadiscio, distante 1613 chilometri al costo di due dollari. L’autista è stato di parola, a titolo di favore, ci ha tenuto liberi i due posti davanti, di fondamentale importanza per alleviare le fatiche del viaggio con una buona veduta panoramica. È il 30 marzo, cade qualche goccia, preludio alla stagione delle piogge, siamo arrivati prima che le strade diventino impraticabili.
Alle 7 saliamo sul bus per essere puntuali alla partenza da Hargheisa, la capitale coloniale della passata Somalia britannica, costruita su un altopiano ad oltre 1300 metri sul livello del mare. Poco prima di accendere il motore un nugolo di bambini, anziani e qualche lebbroso tendono le mani verso l’autista, di nome Tarar, il quale distribuisce loro delle monetine dal finestrino, con un fare rispettoso che apprezzo molto. Con 5-6 scellini, neppure l’equivalente di un dollaro, dona un attimo di gioia ad una decina di persone. È la prassi del “bakshish”, parola presa dal vocabolario d’origine turca molto diffuso nei Paesi arabi per indicare un dono o una mancia.
Tarar ha acquistato personalmente questo autobus in Italia sei mesi prima con l’intenzione di farlo diventare una fonte di reddito. È un tipo serio, taciturno, estremamente concentrato alla guida e a masticare foglie di khat, il diffuso stimolante a spiccato effetto anfetaminico che aiuta a stare alla guida di notte. Coltivato nel Corno d’Africa e nella penisola arabica, il khat è consumato ogni giorno da circa venti milioni di persone ed è, da secoli, parte integrante della vita sociale in questa parte di mondo.
In questo tratto di deserto da altopiano non c’è un’unica pista, come quella percorsa nei giorni passati, ma tanti solchi paralleli, per cui l’autista deve dosare la velocità cercando sempre di spostarsi sul solco meno profondo per seguire la via migliore. In questo caso si sbaglia, il solco cambia di colpo e succede che l’autobus affonda nel fango senza rimedio.
In una trentina cerchiamo di smuovere il mezzo con grande partecipazione, ma niente da fare. È facile costatare la differenza di atteggiamento tra la tracotanza che ostentano quelli del Nord in contrasto con la mitezza e l’affabilità dei somali del Sud. Il primo camion che passa si ferma e rimedia all’inconveniente trainando il bus con una fune. Un’occasione per mettere a fuoco anche questa corriera di colore bianco ed una striscia verde con su scritto Golden Bus, un mezzo scassato per i nostri parametri ma decente per lo standard somalo. Si riparte, abbiamo altri duecento chilometri di sabbia e deserto da attraversare prima di arrivare alla striscia d’asfalto costruita dai cinesi.
Seduti in prima fila ci sembra di vivere l’Africa “in vetrina” che ci esibisce un paesaggio arido in cui a tratti emerge la boscaglia, sabbiosa, composta da alberi bassi e arbusti. Ogni tanto ci fermiamo in qualche villaggio dove non c’è nulla da mangiare, neppure scatolame, bibite o qualsiasi tipo di frutto, solo acqua presa da bidoni sudici e tè dolciastro. In altri invece troviamo latte di cammella, quasi sempre sporco di sabbia e del riso bollito come fosse un budino di colla. Alcuni mangiano carne cruda avvolta da mosche su tavoli posti al sole, ma resto soprattutto colpito nello scorgere un gruppetto di donne intente a bere acqua dalle buche fangose. Le ragazze sono gioviali e decisamente attraenti e, come sostengono gli italiani della Pessina, hanno sguardi davvero seducenti. Apprendiamo che, nella simbologia locale, quelle coi capelli intrecciati in cordoncini lunghi sono le giovani in cerca di marito.
Restiamo incantati anche nel notare con quale amorevole attenzione i pastori si prendono cura dei dromedari che pare ne abbiano consapevolezza. Un centinaio di dromedari si riunisce a lato del pozzo e lì attendono il loro turno. Dopo aver fatto il pieno d’acqua, circa cento litri a testa e goduto dei complimenti dei loro padroni, lasciano il posto agli altri dromedari in perfetto ordine. Curiosa e dolce è pure la nenia cantata con la quale i pastori accompagnano l’animale mentre beve.
Qua e là vediamo anche iene, scimmie, facoceri, minuscole antilopi dik dik, termitai altissimi ed anche un grosso serpente velenoso di colore rosso e nero, appartenente alla famiglia dei cobra, che dicono viva solo ad altitudini superiori ai mille metri.
A Burao, cittadina sulle sponde di un fiume in secca, Tarar approfitta per far scorta di khat. È curioso vedere quanta gente aspetta impaziente questa pianta alcaloide. E il khat è un vizietto che costa, non è a buon mercato. Appena arriva il pickup carico di ramoscelli freschi, questi vengono distribuiti in tutte le bancarelle lungo la via e subito prese d’assalto dalla gente che per prima cosa esamina attentamente i rami con occhio esperto per scegliere quelli migliori. L’uso è semplice: si arrotolano alcune foglie, si mettono in bocca tra i denti e la guancia sinistra e lentamente si succhia e mastica. Essendo una merce altamente deperibile che perde cioè il suo effetto man mano che le ore passano, deve essere trasportata velocemente, a rotta di collo. Solitamente vengono usati dei fuoristrada o dei pick-up dal motore potente e truccato ed è facile vedere questi mezzi sfrecciare per le vie di ogni centro abitato.
Qualche ora dopo, stessa trafila tra venditori che strillano “khat fresco, khat fresco” a Las Anod, il grosso villaggio nella Somaliland, conteso però dal Puntland, l’altra regione che aspira ad una sorta di indipendenza da Mogadiscio. La strada principale taglia il Paese in due e continuiamo senza fermarci fino all’importante crocevia di Garoe, capitale del Puntland, la regione abitata da gente con una spiccata vocazione alla pirateria. Ma il centro ufficiale di questo genere di operazioni risiede più a Nord, nella città costiera di Bosaso, dove si pianificano gli attacchi con i sequestri di navi e dei loro equipaggi che transitano dal Golfo di Aden. A capo Guardafui, sulla punta estrema del Corno d’Africa, s’innalza imponente il faro Francesco Crispi, in onore del primo ministro in epoca coloniale, eretto nel 1930 a forma di un gigantesco fascio littorio di 19 metri ed ora in disuso.
Assorto da ore nella guida e a masticare khat, il taciturno Tarar con l’arrivo della notte comincia a scambiare qualche frase e battuta con noi in un perfetto italiano. Mano male, uno che usa anfetamine e non parla cominciava a preoccuparmi, probabile che gli si sia sciolta la lingua per tenersi sveglio. Incuriosito dalla reputazione anomala del Puntland, provo a chiedere il parere a Tarar che ci sorprende sparando a zero senza timori: “I clan famigliari si spartiscono il potere, sembra di vivere in una terra di nessuno, in realtà qui sussiste una fiorente economia basata sulla pirateria e su traffici illegali vari, tra cui il trasporto di migranti verso gli stati del golfo, il traffico di armi e la collocazione di rifiuti tossici europei”. Si considerano “piccoli pirati” costretti a difendersi dai “grossi pirati”, rappresentati dai governi occidentali. Ne emerge che nessuno qui nega i fatti, sono attività di dominio pubblico, condivise dalla popolazione intera che ne trae benefici come fosse una fonte di reddito qualsiasi.
Da Garoe iniziano i 960 km di strada asfaltata costruita in fretta e furia da 5 mila operai cinesi, ufficialmente donata alla Somalia di Siad Barre, ma secondo Tarar è stata finanziata dall’Arabia Saudita. Approfittiamo per chiedere un suo parere sulla guerra dell’Ogaden e Tarar non esita ad accusare italiani e inglesi: “Prima dell’arrivo dei colonialisti europei i confini della Somalia erano enormi e includevano la regione dell’Ogaden, che venne occupata dall’Etiopia alla fine dell’800. Poi con la creazione dell’Africa Orientale Italiana, l’Ogaden tornò sotto la Somalia fino alla fine della Seconda guerra mondiale quando, di comune accordo, Italia e Gran Bretagna ne tracciarono gli attuali confini. Tenete sempre presente che l’Ogaden è abitato da somali e fa pare di quel vasto territorio che noi chiamiamo Western Somalia”.
Lo provoco dicendo che ormai la guerra è finita e ai somali tocca rassegnarsi, ma Tarar non è per niente d’accordo: “L’Etiopia ha vinto solo grazie all’aiuto di russi e cubani, ci è costata un milione di vittime per colpa di voi bianchi, ma la guerriglia continua e la partita non è ancora chiusa”. E continua: “Prima qui c’erano i russi, adesso ci sono gli americani: i musulmani e il comunismo non si possono sposare”. Le affermazioni di Tarar certamente riflettono il pensiero comune di gran parte del popolo somalo. Un popolo fiero, a prima vista molto pieno di sé, ma in generale si tratta di brava gente.
Lungo tutto il percorso, l’animale selvatico che più incontriamo è la iena maculata, sempre a gruppi di due o tre. Per cambiare discorso sul tema della politica che potrebbe diventare pesante, chiediamo a Tarar se le iene attaccano l’uomo, senza immaginare di provocare una valanga di considerazioni: “Sono animali spesso raffigurati come creature ottuse, a causa del loro ghigno sbavante e dell’andatura cadente, ma le iene sono tanto intelligenti quanto forti. Capaci di pensare, progettare e pianificare i loro attacchi”. E continua: “In Somalia vivono due popoli, l’essere umano e la iena. Sono a milioni e basta arrivare alla periferia di qualsiasi città o villaggio per sentirle sghignazzare.
Tengono d’occhio i movimenti degli umani. Pochi al mondo conoscono la iena quanto un pastore somalo che vive circondato e a stretto contatto con questi animali e ne comprende il loro linguaggio”. Tarar sostiene che le iene dialogano fra di loro come noi umani e ci fa un esempio: “Quando una iena solitaria vede una probabile preda lo comunica ad altre iene per avere aiuto. La cosa straordinaria è che l’aiuto si basa sulla stazza della preda. È come dicesse mi servono uno, due o tre amici, non di più”. Racconta di una iena che ferita al ventre da una pallottola striscia fino ai piedi del cacciatore e mugolando lo guarda con occhi imploranti, quasi a chiedere compassione: “Una iena ferita, quando capisce di non avere scampo, si suicida”.
Ci fermiamo a causa di un forte odore di bruciato proveniente dal motore, guasto che, per fortuna, un meccanico tra i passeggeri in mezz’ora ripara. Sento Tarir sussurrare “Allah fi”, così vuole Dio con una sorta di fatalismo. Considerando il costo irrisorio del passaggio e i frequenti problemi del mezzo, vien da chiedersi come faccia Tarar ad ammortizzare le spese della corriera. Su questa strada “cinese”, che per lunghi tratti sarebbe già da risistemare, il traffico privato è inesistente e ai lati ci sono ancora le pietre miliari delle indicazioni chilometriche con l’effige del fascio littorio, collocate lì in epoca coloniale. Dovunque muri tappezzati da scritte e disegni rivoluzionari contro il colonialismo russo e cubano: “Africa for African! Intravediamo anche un antico manifesto con l’immagine di una piovra bianca schiacciata da scarponi neri fortemente emblematica.
I posti di blocco, segnalati da un cartello con su scritto “Alto – Controla – Stop”, si susseguono numerosi ma non sono molto impegnativi. Appena i militari vedono due bianchi sul bus si irrigidiscono, hanno un attimo di indugio, ma poi il solito visto sul passaporto rilasciato dall’Ambasciata del Cairo li tranquillizza.
La strada migliora quando siamo a circa 200 km da Mogadiscio, mentre il paesaggio, da arido, inizia a colorarsi di un bel verde intenso dalla vallata fertile del fiume in prossimità di Giohar, l’ex Villaggio Duca degli Abruzzi o semplicemente “Villabruzzi”. Qui siamo costretti a fermarci di nuovo per aver terminato il carburante. Mentre Tarar va in giro a cercare di rimediare nafta, Aldo ed io siamo invitati nella caserma per un tè con Alinur, il capo della polizia stradale locale che in modo molto affabile ci tiene a far due chiacchiere in italiano proprio con due abitanti di Modena, una città che conosce, dichiarandosi orgoglioso di avere svolto il corso da poliziotto sull’Autostrada nel tratto da Bologna a Cesena. Apprendiamo che Giohar è stata fondata nel 1920 da Luigi Amedeo di Savoia-Aosta come colonia agricola e in seguito abitata da migliaia di coloni italiani che la resero il principale centro rurale della Somalia. Avevano anche costruito una ferrovia per il trasporto di passeggeri e merci a Mogadiscio, smantellata dagli inglesi dopo la Seconda guerra mondiale, proprio come fecero in Eritrea. Alinur completa il racconto in tono accusatorio: “…per utilizzare rotaie e materiale nelle loro colonie in Africa occidentale. Un atto deplorevole e contrario alla convenzione dell’Aja, secondo la quale avrebbero dovuto salvaguardare le infrastrutture esistenti e non approfittare della situazione per depredare”. Ci informa che a Giohar risiede la tomba e la casa in cui ha vissuto Luigi di Savoia: “Una modesta costruzione in legno trasformata in museo dal Sovrano Militare Ordine di Malta”, ma non abbiamo il tempo per una visita.
Dopo 37 ore di bus, alle 20 del 31 marzo, superiamo l’esile cavalcavia azzurro con la scritta “Arco di Trionfo Popolare” in italiano ed entriamo a Mogadiscio. Il bus parcheggia ad un chilometro dal centro, salutiamo Tarar e camminiamo fino all’Hotel Vittoria, indicatoci come il più squallido della città. È tardi e siamo troppo stanchi per cercarne altri. Il titolare ci chiede 20 scellini in due a notte, ma basta negoziare un attimo che scende a 15, l’equivalente di 2,50 dollari poiché per un dollaro in banca danno 6 scellini e 7 al mercato nero. La trattativa è parte della loro cultura e, nel gioco delle parti, ci si misura attraverso la contrattazione. Il Vittoria è in pieno centro, usciamo per dare un’occhiata ai dintorni e cercare qualcosa da mangiare, quando conosciamo Hussein, un musicista del dancing Giuba che ci fa entrare nel locale come suoi ospiti.
Ci sediamo per ordinare un paio di sandwich e due ragazze chiedono di sedersi al tavolo con noi, mentre Hussein ci fa segno di mandarle via perché quelle vogliono solo scroccare da bere. Siamo troppo stravolti per imporci, lasciamo che bevano un paio di birre e al contempo cerchiamo di capire in che tipo di ambiente siamo capitati. Notiamo subito che la pista è piena di ragazzi che ballano benissimo, agili e carichi di trasporto, tanto da sembrare afroamericani mentre, al loro confronto, il paio di bianchi presenti in pista pare ingessato.
Dopo i Paesi attraversati dall’Egitto fin qui, dove per certi aspetti sembra di essere nel medioevo, non immaginavamo di arrivare in una città musulmana così “aperta”. Per noi una vera rivelazione e liberazione. Un’atmosfera nuova ed entusiasmante, in un’Africa in cui quasi tutti conoscono la nostra lingua e dove sarà interessante soggiornare per tre settimane. Hussein amichevolmente ci saluta dicendo: “Se alloggiavate in un hotel migliore, all’una vi portavo due brave ragazze, ma non in quel cesso del Vittoria”. La scelta non piace neppure a noi e domani cercheremo di trovare un altro albergo.
Prima di coricarmi svuoto le tasche di tutti i bigliettini pieni di appunti presi durante il giorno e li riordino sul taccuino, spesso scrivo fino a notte fonda.
Continua su Wall Street International Magazine