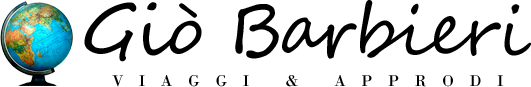Dallo Swaziland e Sudafrica al Lesotho
Stiamo viaggiando nella mitica Zululand, sul treno che da Durban porta al confine con lo Swaziland. La luce del giorno ci mostra sconfinate distese di piantagioni di cotone. Alle 8,30 siamo a Mtubetuba, l’ultima stazione in cui è possibile trovare qualcosa da mangiare, ma la sosta è di appena dieci minuti e bisogna sbrigarsi. Alle 15, in perfetto orario, scendiamo alla stazione di Golala e dopo la dogana raggiungiamo Lavumisa, il paese di confine dello Swaziland. Un manifesto con l’immagine sorridente del re, dal corpo ricoperto di ornamenti tribali, ci avverte che siamo nel “Kingdom of King Sobhuza II”. I due bus per la città di Manzini, purtroppo già partiti, sono accessibili a tutti, sia bianchi che neri. Alla sinistra della dogana c’è un negozio di alimentari dotato di juke box e bigliardino e chi entra si mette subito a ballare o a giocare. Gli avventori sono sereni e cordiali, qui non si avverte l’atmosfera oppressiva dell’apartheid. Il titolare sbotta: “Il Sudafrica è ancora una colonia bianca che lotta per l’indipendenza, noi siamo indipendenti dal ‘68 ma abbiamo però altri problemi”.
Il giovane doganiere Josia, in cambio di una inutile borraccia, si impegna con zelo a trovarci un passaggio in auto, per molte ore e senza successo. A fine giornata ci rassegniamo a sistemarci nell’unico hotel del villaggio, alloggio che avremmo voluto evitare essendo per noi dispendioso. Nessuno cambia la valuta, non possiamo neppure pagarci il passaggio in bus e, il mattino seguente, non ci resta che fare l’autostop. Alle 8 siamo di nuovo in dogana ma nessuno ci carica fino alle 13 quando, a fatica, un indiano decisamente agitato che va a Manzini ci fa salire nella sua auto. Nelle tre ore del tragitto prova a chiederci i soldi per la benzina ma capisce presto che è fatica sprecata. La cittadina ci appare totalmente priva di fascino, dotata di un piccolo centro con edifici moderni, di un incrocio con molto traffico, qualche supermercato e dall’aspetto decisamente anonimo. Gli hotel sono più costosi che in Sudafrica per cui ne cerchiamo uno che faccia al caso nostro, in periferia.
Sorta a cavallo del ‘900, quale centro amministrativo per inglesi e boeri, Manzini venne distrutta a seguito dei rapporti conflittuali tra i due colonizzatori che sfociarono nella seconda guerra anglo-boera, terminata nel 1902 con la supremazia britannica che pose fine agli stati boeri, quali la Repubblica del Transvaal, lo Stato Libero dell’Orange e la Colonia del Capo. La vita degli stranieri si svolge principalmente dentro ai grandi hotel e al casinò, mentre la parte più interessante e folcloristica si trova al mercatino delle pulci in cui sono esposti variopinti batik dipinti a mano.
Qui incontriamo un estroverso italiano di nome Peppy, che vive da molti anni in Sudafrica. Anche lui è turista in Swaziland. Ci offre la colazione ed insiste per ospitarci in caso tornassimo a Durban. Si avverte subito la grande voglia che ha di parlare in lingua italiana. Secondo Peppy il Sudafrica è un paradiso: “Cambio quattro ragazze la settimana, le porto nei migliori ristoranti, se fossi in Italia, con quello che costa la vita da noi non potrei mai permettermelo”. In altre parole: “Gli occidentali in Sudafrica sono considerati importanti, fanno subito parte di una élite, diventano qualcuno, mentre a casa loro non sono nessuno”. Peppy è automunito, ci porta in giro per le colline circostanti ed infine nelle due discoteche all’interno del casinò di Manzini: la Happy Valley e la Why Not, a 10 km dal centro sulla via per Mbabane. Peppy però, disinteressato alla musica, si lascia trasportare da un bisogno irrefrenabile di parlare a raffica esprimendo alcuni concetti che ritiene comuni a gran parte dei bianchi residenti in Sudafrica: “Credimi, i neri stanno bene con i bianchi, il razzismo è solo propaganda comunista. È vero che i neri non possono venire nei posti per bianchi, ma nemmeno i bianchi vanno nei posti per neri”.
Conclude dicendo: “Se la polizia è gentile con i bianchi e non con i neri è solo perché i neri sono stupidi”. Ho taciuto per farlo smettere di parlare, attratto e incuriosito dalla miriade di ragazze di colore dal sorriso ammiccante rivolto ai bianchi, cosa inibita alle donne in Sudafrica. Visini dai lineamenti delicati spesso in contrasto con gambe possenti, particolarità delle donne Swazi. La cameriera al take-away Three Sisters, accanto alla trattoria Italia, lamenta che un operaio in Swazi percepisce un misero salario mensile che varia da 20 a 40 rande, mentre in Sudafrica il costo della vita è inferiore e lo stipendio è invece molto maggiore, da 150 a 200 rande. Lei, come tanti, nonostante l’apartheid vorrebbe andare a lavorare in Sudafrica, confermando in parte il discorso fatto da Peppy.
Entriamo a curiosare alla stazione ferroviaria di Manzini, da dove parte il treno che in sole cinque ore conduce a Maputo. Mi piacerebbe molto andare a dare un’occhiata alla capitale del Mozambico ma, a causa della guerra civile, pare non sia così facile ottenere il visto e al momento, ci dicono, i treni non portano passeggeri ma solo merci.
Saliamo sul bus per Mbabane, siamo gli unici bianchi. Appena fuori Manzini inizia la salita che in 50 km di verde e rigogliosa montagna conduce alla capitale, situata ad un’altitudine di 1150 metri. Sulla via il bus sosta a Lobamba, nella Valley of Heaven, sede della residenza reale, del parlamento e del complesso Royal Swazi Sun Hotel, con casinò e campi da tennis che attraggono molti turisti sudafricani. Magnifico il clima subtropicale d’altura, ma per il resto anche Mbabane, come Manzini, è una piccola città con alcuni edifici moderni privi di attrattiva. Per il nostro standard da viaggiatori gli hotel sono tutti costosi tranne i bungalow del Jabul Inn, di fianco alla caffetteria Casbah e, a seguire, una serie di pub con musica afroamericana “sparata” a tutto volume, frequentati da accaniti bevitori e prostitute. Bevitori cordiali, dai toni amichevoli che in nostro onore cantano pezzi di vecchie canzoni italiane giunte quaggiù chissà come. Le ragazze del bar criticano apertamente il loro sovrano a causa della poligamia, usanza secolare che gli permette di collezionare un’infinità di mogli tramite il rito annuale della cosiddetta Reed Dance, ovvero da 30 a 50 mila ragazze in età da marito, dai 13 anni in poi, ballano in abiti tradizionali e a seno scoperto davanti al re il quale dovrà sceglierne una come moglie. Tradizione di chiaro stampo maschilista che però la quasi totalità delle donne vive con grande naturalezza. La festa dura una settimana, ma secondo le ragazze del bar la prescelta è nota fin dall’inizio. Il paradosso sta anche nel fatto che il re ha emanato una legge che obbliga le donne alla castità fino a 24 anni, e in effetti nei pub sono tutte “maggiorenni”. L’anziano barista conclude sottovoce: “Nello Swaziland vige una monarchia assoluta che per certi versi è come una dittatura”.
All’alba lasciamo Mbabane in autostop grazie ad un farmacista swazi che ci porta al confine. Se per le 14 riusciamo a raggiungere la cittadina di Breyten, da lì c’è il treno che porta a Johannesburg, distante 380 km. In dogana vediamo un gran viavai di sudafricani che attraversano la frontiera attratti dai casinò ma in gran parte sono qui per far benzina poiché nello Swaziland costa meno. Accettano di darci un passaggio fino a Johannesburg Carol e John, una coppia di residenti inglesi estremamente gentili, evitandoci così di andare a Breyten. Sentiamo che nel parlato Johannesburg diventa “Josburg”, infatti, per i sintetici nordici, mi pareva che fosse un nome troppo lungo. Ci avvertono che stiamo andando in una città dove bisogna fare molta attenzione: “I neri sono aggressivi e i bianchi hanno paura. Molti bianchi hanno lasciato Johannesburg per l’alto numero di assalti, rapine ed omicidi. È una città buona solo per lavorare e fare soldi, abitata anche da circa 150 mila italiani, tutti ben inseriti”.
All’arrivo, i due amici fanno addirittura 60 km in più solo per portarci in centro ed aiutarci a cercare un hotel, quasi per proteggerci. Il centro, che qui chiamano “zona viva”, è nel quartiere di Hillbrow, su di una collinetta che raduna hotel, ristoranti, pub, disco e cinema. Cambiamo tre hotel per finire in una camera tripla alla più conveniente e piacevole pensione Soper Lodge, tipico ambiente per viaggiatori gestito da una famiglia di brave persone, fiamminghi dall’aria un po’ smarrita. Nel prezzo sono compresi i tre pasti; il cibo è buono, ma curiosamente ogni giorno il nome dei piatti cambia mentre il cibo è sempre lo stesso. Una breve e luminosa Pretoria Street richiama la nostra attenzione sulla massiccia presenza di attività commerciali gestite da italiani, a cominciare dalle pizzerie: La Baita, Toscana, Bella Napoli, Il Gattopardo. Sono connazionali anche i gestori di un’edicola, i negozi di alimentari, con grana e tortellini e via di seguito, mentre nei bar servono in modo regolare il caffè espresso all’italiana.
Ovunque si vedono le scritte “Whites Only” e “Colored and Asiatic Only”. Perlustriamo la città per giorni ed ovviamente occorre tempo per capire, tuttavia a noi non pare il luogo così pericoloso descritto da tanti. Si dice d’accordo anche Peter, un viaggiatore inglese nel nostro stesso hotel: “Johannesburg è meno pericolosa che l’Europa, qui al massimo ti rubano dei soldi mentre a Londra può succedere che uccidono non per soldi ma perché è divertente farlo – “it’s fun to kill someone”. Certamente, vivere in un luogo è diverso che esserne di passaggio.
Continua su Wall Street International Magazine