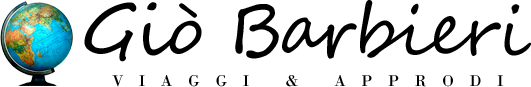Saigon
Eccomi di nuovo, 50 anni dopo, all’aeroporto di Saigon e per certi versi non è cambiato molto, allora c’erano i soldati americani oggi vedo McDonald. Per gli americani le guerre sono sempre un affare, d’altra parte il loro stile di vita attrae molti popoli. Allora c’era la guerra e in mezzo secolo tutto cambia ma la vitalità di questa città, se paragonata al resto del paese, è rimasta immutata.
Alloggio nella zona di Pham Ngu Lao, nel Distretto Uno, un dedalo di vicoli in cui si concentrano decine e decine di semplici ma confortevoli hotel, guesthouse, ostelli ed alloggi popolari di vario genere, uno accanto all’altro. La differenza con l’austera Hanoi è visibile ovunque, in entrambe si celebra la vita ma in maniera diversa, tanto da sembrare, per certi versi, ancora due Paesi distinti. A Saigon regna un’atmosfera leggera e informale, popolata da freack e giramondo occidentali, con una vita notturna straordinariamente intensa, un’infinità di locali con musica rock e blues dal vivo ed anche ragazze in cerca di compagnia, tra miriadi di bancarelle e venditori ambulanti che offrono cibi e oggetti dovunque e a tutte le ore. Anche l’incessante rombo di migliaia di motorini a Saigon è più disordinato e frenetico della capitale. Qui si respira una grande dinamismo e si finisce per esserne contagiati. I numerosi parchi e parchetti cittadini poi, radunano un’infinità di gente di ogni età che fa ginnastica o tai-chi, scolaresche che suonano accanto a chi danza, balla o pratica lezioni di arti marziali, gioca a calcio o amoreggia, ognuno per conto proprio in piena libertà e serenamente. È una dimensione sociale invidiabile per il senso di benessere che trasmette e di cui la gente forse non se ne rende conto.
Trascorro i primi due giorni in giro a piedi per vedere i luoghi noti della metropoli, basta fermarsi spesso in uno dei tanti bar a bere, poiché l’umidità rende l’aria pesante. Prima sosta al mercato Ben Thanh, una delle strutture più antiche di Saigon e, dopo, alla Cattedrale di Notre Dame, l’edificio neoromanico in mattoni del 1883 che domina il cuore della città governativa. Alla sua destra il grandioso palazzo della Posta Centrale del 1891, progettata da Gustave Eiffel. Di fronte alla cattedrale inizia Dong Khoi, la via dello shopping che ancora oggi preserva memorie e testimonianze di quei giorni di guerra terminati il 30 aprile 1975. Subito al primo incrocio con Ly Tu Trong (ex Gia Long Street), sulla sinistra al numero 22, vedo la casa con la torretta che servì da piattaforma all’elicottero che fece evacuare gli agenti della CIA il giorno prima della caduta di Saigon. Scena resa celebre dal fotografo olandese Hubert Van Es. Ancora pochi passi lungo Don Khoi e sempre sulla sinistra, affacciato sul piazzale del Teatro dell’Opera, trovo il mitico Continental Palace Saigon, vera istituzione per la quasi totalità dei corrispondenti stranieri, prima con la guerra d’Indocina contro i francesi (1946-1954) e dopo con quella del Vietnam contro l’America. Sia il Time che il Newsweek avevano le loro sedi al secondo piano dell’hotel. Parcheggiate davanti al Continental, a testimoniarne il luogo di prestigio, una fiammante Ferrari 448 Pista che con orgoglio mi riporta ai lidi di casa. Sul lato opposto del piazzale fanno mostra di sé i dieci piani del Caravelle Hotel, altro tempio storico di quel periodo bellico, ex sede di molte televisioni internazionali, tra cui ABC e NBC, e di alcune ambasciate occidentali. Nel 1964 una bomba esplose al quinto piano, non ci furono vittime ma negli undici anni successivi le finestre nell’angolo arrotondato dell’edificio furono sigillate col nastro adesivo. Merita di salire all’altrettanto celebre Saigon Saigon, il bar del terrazzo all’ultimo piano, da dove si gode anche una magnifica veduta del Teatro dell’Opera (1897), uno degli edifici più emblematici che riporta ai fasti della belle époque francese. Nella via di fronte, Le Loi, c’è anche il Rex Hotel, dove ogni giorno alle 17 gli alti ufficiali americani incontravano la stampa per gli aggiornamenti sull’andamento della guerra, comunicati spesso ritenuti dai giornalisti una caterva di bugie. Qui incontro Fred di 76 anni, ex ufficiale americano che racconta di essere stato arruolato nel 1969 e ringrazia ancora il cielo perché era destinato in Vietnam ma poi, per pura fortuna, lo mandarono in una tranquilla base USA in Germania.
Ricordo quando nel ‘69, alla ricerca di informazioni utili a risalire il Mekong nel Laos dalla Cambogia, all’epoca dominata dai Khmer Rossi, con un caldo infernale percorremmo tutta via Pasteur a piedi alla ricerca dell’ambasciata italiana e, infine, la trovammo in prossimità di viale Ham Nghi, in una posizione davvero poco felice essendo accanto a quella americana, super recintata da filo spinato perché la più attaccata dai vietcong. All’interno della nostra sede diplomatica trovammo tutto sottosopra, con pacchi, fogli e carte sparsi ovunque sul pavimento, impiegate che parlavano fra di loro urlando in evidente stato di forte stress da panico. Emblematica, sul caminetto, una statuina in gesso che raffigurava un Cristo sanguinante. Il segretario era gentile ma non sapeva nulla, mentre la segretaria poteva forse anche sapere ma era alterata fuori misura. Stavano animosamente parlando di un napoletano che non si capiva come fosse riuscito ad introdurre a Saigon un intero container di scarpe italiane usate. Alla fine riuscimmo a strappare ai due impiegati il nome della persona che in seguito avrebbe risposto ai nostri quesiti: un certo Cav. Forsinetti, console italiano a Phnom Penh. Dal Cavaliere apprendemmo anche una notizia in esclusiva, sconosciuta in Italia: suo figlio Bruno aveva sposato la bellissima principessa Norodom Buppha Devi, figlia del principe Sihaunuk, sovrano della Cambogia. Era prima ballerina di Cambogia, ritratta nelle cartoline postali e noi “ce la spedimmo a casa”. Chissà com’è oggi Keo Chinsita Forsinetti, il figlio italo cambogiano che all’epoca aveva quattro anni!
Usciti dall’ambasciata, raccolsi per strada alcuni bossoli di M-16 e AK-47, certamente usati durante l’offensiva del Tet dell’anno prima e li tenni come testimonianza. Così come le curiose cartoline postali con scene di guerriglia urbana scattate dagli americani, che mostravano i combattimenti come un gioco. I bossoli erano un po’ dappertutto, si capiva bene che era stata una battaglia cruenta, strada per strada.
Quella lontana guerra si è come materializzata quando sono arrivato a Cu Chi, l’estesa rete di tunnel sotterranei usata dai vietcong durante il conflitto, simbolo della tenacia nordvietnamita. Per i giornalisti della BBC, Mangold e Penycaya, questa è stata la zona più bombardata, mitragliata, irrogata di gas, cosparsa di defoglianti e devastata di tutta la storia militare di sempre. La sezione aperta al pubblico più visitata, modificata per dar modo ai turisti di scendere per qualche tratto, si trova nei pressi del villaggio di Ben Dinh, a circa 50 km da Saigon. Queste gallerie, che raggiungevano la Cambogia e si ramificavano per circa 250 chilometri, ebbero un ruolo determinante nella guerra di sfinimento contro gli Stati Uniti, che proprio qui avevano una delle basi logistiche più importanti. Una città sotterranea, con ospedali, mense e camerate dove vengono illustrati alcuni dei loro semplici ma geniali stratagemmi per evitare di essere localizzati. A metà percorso, dopo la presentazione trappole mortali, usate nella giungla, ed i relitti bellici, è possibile provare l’emozione di sparare al poligono con un AK-47 russo (Kalashnikov) o un M-16 americano. La garbata gentilezza di ragazze vestite da vietcong, sembra contrastare con il sottofondo di sparatorie, esplosioni, scontri a fuoco, ma la simulazione di quella orrenda guerra si stempera grazie ad un percorso che la rende avvincente ed accettabile.
Per completare il percorso di questa tragedia entro nel famoso War Remnants Museum, che raccoglie tutto ciò che hanno vissuto i vietnamiti di allora. Superbamente allestito, tanto che non credo esista un altro museo al mondo capace di trasmettere con tanta efficacia e lucidità gli orrori della guerra. Realizzato nel settembre del 1975, nei decenni ha cambiato più volte nome per diventare Casa dei Crimini di Guerra e infine Museo dei Residuati Bellici, definizione diplomatica che ha cancellato i precedenti riferimenti ai crimini di cinesi, francesi, regime fantoccio e americani. In questo edificio a due piani sono esposte immagini e testimonianze decisamente toccanti, molte delle quali diventate tristemente famose negli anni ’60 e ’70, come il massacro di My Lai ed altre atrocità compiute dall’esercito americano. L’opinione pubblica americana cominciò a prendere le distanze da questo conflitto quando prese coscienza degli errori e degli orrori della politica americana, come le stragi dell’operazione Speedy Express lanciata dalla 9a Divisione nel Mekong per fare salire nelle statistiche il body count, ovvero il numero dei morti vietnamiti ad appannaggio dell’informazione mediatica. Al solo scopo di bilanciare il conteggio dei morti, quella Divisione arrivò ad uccidere 6-7 mila civili indifesi. Inoltre, l’uso dell’agente arancio impoverì l’intera popolazione rurale, facendo salire così un odio irreversibile verso gli USA e il governo sud vietnamita. Evidentemente per gli americani, sia che fossero vietnamiti del Sud o del Nord, erano tutti “musi gialli”. Particolarmente raccapriccianti le foto che mostrano le deformità delle persone colpite dagli agenti chimici i cui effetti sono sui neonati a distanza di due generazioni. C’è tanto da vedere e considerare, dai ritratti dei giornalisti periti, ai più sofisticati strumenti di distruzione e morte che l’uomo seppe inventare a quei tempi, anche se oggi, con le nuove tecnologie, potrebbero sembrare primitivi. In questo museo i vietnamiti ripagano gli americani con la stessa moneta, riuscendo a dare un’immagine ripugnante degli invasori. Il cortile esterno è occupato da grossi residuati bellici americani, come elicotteri, aerei, carri armati, cannoni e cingolati vari. Un’immersione totale in quella brutta storia lontana nel tempo. I visitatori stranieri delle generazioni successive alla guerra giungono in Vietnam quasi completamente ignari di quel periodo ma sicuramente tornano a casa con una maggiore consapevolezza.
Tornato in albergo, dove la tv che ho in camera non disdegna programmi in inglese, chiedo all’impiegato se i vietnamiti non hanno rancori verso francesi o americani e la sua risposta mi lascia basito: “Nessun risentimento. Se il destino ci ha mandato la guerra, per noi è una colpa da espiare per cose fatte dai nostri antenati, non importa chi sia il nemico”.
Il giorno dopo lo dedico alle ricerche di frammenti di quel passato, senza troppe speranze. Salgo su un moto-taxi che mi conduca al quartiere di Cholon, nella vaga ipotesi di localizzare l’hotel Hawaii, nostro alloggio di mezzo secolo fa. Non lo trovo, probabilmente non esiste più, ma nel tragitto rivedo Hang Bong, la strada dove cinquant’anni fa ho assistito ad un brutale linciaggio che in parte spiega l’atmosfera rovente che si respirava in quei giorni, rimasto ben impresso nella mia mente. Un pulmino Volkswagen su cui viaggiano due ragazze e due ragazzi vietnamiti, tra cui l’autista e due grandi e grossi soldati americani in uniforme, al semaforo toccarono leggermente la moto che gli stava davanti. Il motociclista scese, apri la portiera del pulmino e rifilò una serie di cazzotti all’autista. Quattro militari vietnamiti di passaggio, subito accorsero infuriati e rifilarono altri pugni, testate, gomitate e calci al driver ed alle due ragazze. Frantumarono poi a calci il vetro frontale del pulmino per trascinarli fuori dall’abitacolo e picchiarli meglio. Anche i due americani scesero dalla parte opposta e si misero in disparte sul marciapiedi ad osservare, senza muovere un dito. L’autista era ormai moribondo, per terra e in un lago di sangue. Una delle ragazze, anche lei sanguinante, lo copri col corpo, ma i militi continuarono a sferrare calci in faccia e nella schiena coi loro stivaloni pieni di borchie. Intervenne un poliziotto, detto sceriffo, che estratta la pistola sparò quattro colpi per aria, ma questi continuarono a dare calci senza curarsene. Non solo, ai quattro militari si unirono anche dei passanti a picchiare su quei corpi con uguale accanimento. Tutti li picchiavano in un linciaggio collettivo, mentre i due americani, enormi, rimasero in disparte, immobili, a guardare, visibilmente terrorizzati. L’autista e la ragazza vennero portati via agonizzanti, apparentemente privi di vita. Questo testimonia l’ostilità di gran parte della popolazione per le ragazze che socializzavano coi bianchi, indipendentemente dal fatto che fossero prostitute o no. Tutt’ora molti vietnamiti maschi non vedono di buon occhio le coppie miste e tra loro sono molto solidali: se ad uno straniero capita di litigare con un vietnamita arrivano subito altri a dargli man forte a prescindere da chi ha ragione.
La mattina seguente mi alzo deciso a camminare fino al memoriale del venerabile Thich Quang Duc, il monaco buddista che il 10 giugno del 1963 si cosparse di benzina e si immolò per protesta contro le leggi repressive ed anti-buddiste del governo sud vietnamita di Ngo Dinh Diem. Un tranquillo parchetto circonda la statua in bronzo che lo raffigura avvolto da fiamme, eretto nel punto in cui avvenne il suicidio, con alle spalle il bassorilievo che documenta la storia di quell’episodio appartenente ai miei dolenti ricordi di ragazzino. L’ultimo giorno lo trascorro a perlustrare liberamente i vicoli ed apprezzo il rione di Pham Ngu Lao, una sorta di vivace backpackersville frequentato da globe trotter che rendono l’atmosfera piacevolmente spartana. La sera, discoteche, bar, ristoranti e centri di massaggio, uno accanto all’altro, attraggono una moltitudine di giovanissimi vietnamiti, da movida locale, che rendono difficile il camminare. Seguo il lungofiume attorno al futuristico grattacielo della Betexco Financial Tower e per cenare scendo nel grande spazio del Downtown Food, ricavato sotto il parco 23/9. Trova posto al mio stesso tavolo Eva, francese di Tolone, la quale mi racconta di avere vissuto 4 anni a Saigon quando era ragazzina, dai 10 ai 14 anni, e che da una decade torna qui a svernare per tre mesi ogni anno. Eva è entusiasta del cibo e del Vietnam in generale e ci tiene a sottolineare che qui, forse senza saperlo, la gente si gode la vita più che altrove nel mondo.
Riflettendo su questo viaggio, sicuramente sono stato affascinato dalla bellezza dei paesaggi in cui natura e cultura si fondono armoniosamente alla ricerca di un equilibrio fra tradizione e modernità, spiritualità e un cauto profano. Ho colto nel paesaggio la stessa armonia che hanno le donne nel muoversi, nella gestualità ricca di grazia ed equilibrio. Si respira in generale un’energia positiva dove l’intraprendenza, l’efficienza, la sinergia nel fare collettivo danno all’ospite la percezione di essere accolto e tutelato. La popolazione, più sobria al Nord e più libera e leggera al Sud, è ovunque gentile, sorridente e disponibile. Dai monumenti ai siti dedicati alla memoria della guerra si colgono altri tratti del temperamento dei vietnamiti che probabilmente sono stati decisivi nella vittoria contro i francesi prima e gli americani dopo. Il turismo di massa è ancora contenuto e forse è per questo che il Vietnam ha mantenuto una sua “innocenza”.
Continua su Wall Street International Magazine